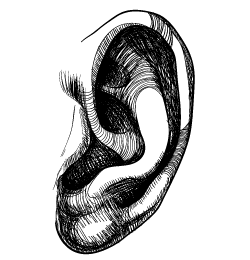
La solitudine
del serpente
Kobe Bryant.
Prendeva nota di tutte le loro giocate. Le posizioni dei piedi per il tiro, le virate quando fintavano, i tagli senza palla per smarcarsi. Stava alzato fino alle 3 di notte anche se il giorno dopo doveva andare a scuola. Studiava i numeri del loro repertorio per riempire il suo, come quelli che calcolava per riempire il quaderno in classe. Per evitare di entrarci ogni mattina con lo sguardo tutto stropicciato, iniziò a farsi mandare dall’America le registrazioni delle partite. Un servizio a domicilio gli spediva le cassette Vhs a casa, a Reggio Emilia. Sapeva che doveva farlo se voleva diventare uno come loro. Premeva il tasto del fermo immagine o del ralenti e rivedeva decine di volte la postura e i movimenti di Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan.
«Chi è questo ragazzino?» Tra i cronisti c’era molta curiosità nel 1996 attorno a quello studente della Lower Marion High School cresciuto così in fretta di statura e di testa. Non aveva nemmeno 18 anni e stava per fare il balzo più importante della sua vita. Saltare 3 anni di college e iniziare la carriera nella lega professionistica di basket degli Stati Uniti. Sembrava un azzardo per molti. Soprattutto se chi stava per saltare aveva vissuto fino a 13 anni in Italia. Secondo gli esperti, rispetto ai coetanei gli mancava la preparazione atletica delle high school americane. Ci sono un sacco di giocatori di talento nella Nba: lo spettacolo sportivo più seguito nel mondo vive grazie a quella reazione chimica di tecnica e atletismo che si innesca in ognuno di loro sui campi delle città americane. Ma alla fine nessuno aveva quella durezza mentale che solo pochi sanno mettere in campo. Qualcuno quel giorno la vide in Kobe Bryant.
Fu solo per fare un favore a un amico se Jerry West accettò di assistere al provino di uno sconosciuto ragazzino di Philadelphia. Arn Tellem era l’agente che Sonny Vaccaro aveva scelto per curare i contratti in Nba di Kobe Bryant. Lui era la tredicesima scelta su 14 giocatori nel Draft dell’Nba di quel 26 giugno, ma il general manager dei Los Angeles Lakers sapeva riconoscere un giocatore di talento dal finestrino di un treno in corsa. Da quando faceva il talent scout Jerry West aveva sempre sostenuto che «si può vedere quello che un giocatore sa fare in campo, ma è difficile capire che cosa dentro lo muove per fare le meraviglie che sa fare sotto il canestro, dalla distanza, in sospensione, dalla lunetta».
Il come fa le cose è quello che interessa allo spettatore: è per quello che paga il biglietto. Il come lavora è quello che interessa al datore di lavoro: è per quello che gli paga lo stipendio. È lì, in superficie: basta avere un buon occhio e tutti possono vederlo. Ma il che cosa lo muove, ah be’ quella è un’altra faccenda. È la parte più profonda della questione, quella che ti fa capire chi hai davvero di fronte.
Jerry West la vide nella grande quantità di lavoro individuale che Kobe Bryant doveva avere svolto in passato per arrivare a quei movimenti. Nel numero di ore che quel ragazzo doveva avere impiegato per arrivare a quella padronanza. Era riassunto tutto lì, in quel provino che, se gambe e braccia avessero potuto parlare, sarebbe stato un colloquio di lavoro.
«Va bene. Basta così: lo prendiamo». Lo disse prima all’agente del giocatore, Sonny Vaccaro, poi al diretto interessato. Jerry West considerò quel provino il migliore che avesse mai visto in carriera: «Puoi riconoscere il talento di un giocatore da quello che sa fare in partita, ma è molto più difficile cogliere quello che lui ha fatto fuori del campo».
Preferiva farlo di mattina presto. Alle 5 Kobe era già in palestra a fare esercizi. Quando la sua squadra si trasferiva da una città all’altra per una partita poteva arrivare anche alle 3 del mattino. I suoi compagni prendevano la strada dell’albergo, lui imboccava quella della palestra. Durante il viaggio in aereo il resto della squadra dormiva, lui guardava la registrazione della partita che aveva appena finito di giocare. Se la lunghezza del viaggio lo permetteva, gli rimaneva il tempo per studiare i filmati della squadra della città dove sarebbe atterrato. C’era la prossima partita da giocare e lui prima dei suoi compagni avrebbe già saputo come giocarla.
I Lakers si allenavano 2 volte al giorno. La prima seduta era alle 10 del mattino. Lui era lì già dalle 8. I suoi compagni staccavano alle 12, lui si fermava fino alle 2. Tutti ritornavano alle 7 di sera, lui era dalle 5 che rimbalzava insieme alla palla. Gli altri lo salutavano alle 9, lui se ne andava solo alle 11. Fu in quella differenza di ore che 198 centimetri di palleggio-arresto-tiro diventarono Kobe Bryant.
«Il segreto è il ritmo. Il difensore non può farci niente. Non gli resta che indietreggiare». Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Mentre ondeggiava di fronte all’avversario, la palla passava da una mano all’altra in mezzo alle gambe al ritmo di una percussione indiavolata. Quell’uno-contro-uno sarebbe diventato il suo infernale marchio di fabbrica per gli avversari, fuori e dentro il campo. Un paio di finte, un taglio ed era subito al ferro.
Fu Pamela Fox ad attaccarlo al muro di casa, al 1224 di Remington, un sobborgo di Philadelphia. Da brava madre nutriva il suo organismo di ragazzino a tavola, come alimentava il suo perfezionismo di adulto a canestro. Era quel giocare contro la sua ombra che portò sempre con sé anche quando dovette iniziare a farlo in una squadra: gli avrebbe causato un sacco di guai con i compagni, e non solo.
I ripetuti viaggi in Colorado per le udienze preliminari interferivano con gli allenamenti e le partite. Sarebbero potute diventare un danno per qualunque giocatore e per qualsiasi squadra: non per i Lakers se il giocatore in questione era Kobe Bryant. Sotto di 2-0, sembravano ormai spacciati nelle semifinali di conference contro i San Antonio Spurs. Per gara 4, Bryant arrivò con un jet all’ultimo minuto dopo un’udienza in tribunale. Senza la sua capacità di dividere la vita in compartimenti stagni non sarebbe mai riuscito a dare il suo contributo a una delle più improbabili rimonte nella storia della Nba. Ora che in quell’accusa ci era immerso fino al collo, avrebbe dovuto abituarsi a dividere la sua vita di atleta da quella di imputato.
Quella sera del 30 giugno del 2003 non sapeva di avere diviso la stanza numero 35 del Cordillera Lodge & Spa a Edwards, in Colorado, con una ragazza che aveva già avuto rapporti con altri 2 uomini. Solo nell’agosto del 2004 la Corte di Giustizia fu informata che gli indumenti intimi dell’impiegata della reception avevano tracce del dna di 3 uomini differenti. Il processo a suo carico si stava smontando. Invece di due guardie del corpo e di un personal trainer che quella sera lo accompagnavano, Kobe avrebbe avuto bisogno solo delle parole di un vero amico. «No, Kobe. Non farlo, dai». Fu invece vittima di un nemico invisibile: l’altro sé stesso che portava nel suo isolamento ogni volta che ne aveva bisogno.
«Fammi entrare coach perché io fò canestro». A ogni partita c’era sempre almeno un paio di genitori al seguito della squadra che si lamentavano di quel ragazzo americano che non passava mai la palla ai loro figli. Così, l’allenatore ogni volta era costretto a isolarlo in panchina e a farlo entrare solo per 5 minuti. Ne giocò uno in più il 3 novembre 1996 quando entrò dalla panchina per il suo debutto in Nba contro i Minnesota Timberwolves. Aveva 18 anni e 72 giorni. Non fece nemmeno un punto: sbagliò 10 tiri di fila. Ma se qualcuno a Los Angeles quella notte stessa fosse entrato nella palestra di una scuola lì vicino, avrebbe sentito il rumore dei rimbalzi a terra e il fruscio della palla che passava l’imbuto della rete. Era Kobe Bryant che sfidava il canestro alle 3 del mattino.
Andrea Ingrosso
Copywriter – Autore di scrittura per le aziende.
© 2021 Mamy
