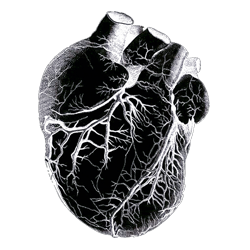
Che cosa c'era
sotto i panni di scena
di Robin Williams.
Erano le nove e mezzo e non si era ancora alzato. In famiglia si sentivano sollevati al pensiero che fosse riuscito a passare una notte tranquilla: quelle ore di sonno in più avrebbero dovuto esserne la prova. Ma alle undici non era ancora uscito dalla sua stanza: gli animi iniziarono a farsi qualche domanda. Non trovò risposta il biglietto che fecero scivolare sotto la porta. Con una graffetta riuscirono ad aprirla: Robin era sospeso in aria con una cintura attorno al collo.
Era così alto il suo peso sul set che, nella bilancia tra essere attore ed essere sé stesso, il piatto pendeva sempre dalla sua parte. I critici glielo avrebbero fatto notare in ogni film: c’era troppo Williams nelle parti che Robin interpretava. Più che entrare nel personaggio era un cameo quello che faceva uscire dalla sua persona. Il pubblico vedeva Robin che faceva Williams sotto gli abiti di scena del disc jockey radiofonico Adrian Cronauer o del professore di letteratura John Keating. Eppure, non era mai contento di come gli riusciva la parte. Avrebbe pagato di tasca sua per rifare le riprese dei monologhi davanti al microfono della radio. Ma per i produttori di Good Morning, Vietnam non c’era nessuna ragione di farlo: erano spettacolari per quanto veloci correvano. Vietato fermarsi: mentre stavi lì a capire l’ultima battuta, Williams ne aveva già fatte altre due.
Quando il suo cameo combaciava con il personaggio del film, Robin scendeva dalla superficie dell’uomo di spettacolo che era per esplorare che cosa c’era sotto. I panni erano diversi, ma le esperienze di vita che li animavano erano le stesse. Fu liberatorio mettersi in quelli di Parry, un barbone che viveva sotto il ponte di Brooklyn. Perché sotto il pelo dell’apparenza della popolarità poteva affrontare le situazioni vissute in passato e analizzare da ogni angolo la spigolosità dei motivi che lo avevano portato a rimuoverle. Complice di questa rimozione era stata la recitazione. Recitare in La Leggenda del Re Pescatore invece avrebbe avuto il compito di ricordargliele, anche se la fama era sempre lì che lo pedinava in ogni angolo del set e lui messo all’angolo si chiedeva se non vedere Robin sopra i panni del personaggio poteva deludere i suoi fan.
Quando decise di mettersi sotto i panni di Mrs Doubtfire la corrispondenza tra fiction e realtà si sarebbe fatta ancora più familiare. Se lo sarebbe ricordato mentre il suo matrimonio con Valerie andava in pezzi e Robin aveva bisogno di suo figlio, come Zak aveva bisogno di lui. Otto pezzi sovrapposti in schiuma di lattice e strati di vernice colore carne: erano necessarie quattro ore per applicarla sopra la faccia di Robin. Ma se la maschera riuscì a nasconderne la mascolinità, non bastò a occultare la sua incontinente energia recitativa. Più che Ifigenia Doubtfire a prendere vita sopra il corpo di un uomo, era Robin Williams che recitava nelle vesti di una donna.
Dopo una giornata passata sul set era diventato un rito serale. Gli bastava un giro tra gli esclusivi club notturni per finire a casa di uno spacciatore. All’interno della troupe non era un segreto che tirasse con il naso e alzasse il gomito: lo aveva fatto dall’inizio della carriera. Poi aveva rigato dritto per 20 anni in una improbabile convivenza con quella parte di sé che lo teneva sotto scacco. «Quando ricominciai, ricominciai di brutto». A quel punto, tra il riemergere dal fondo e il ricaderci perché si diceva «Ehi, è solo un goccio» non c’erano più ostacoli.
Tutto avveniva alla luce dei riflettori: il fondo della bottiglia era sempre ben visibile e la droga faceva da sfondo a una scena che Robin sapeva recitare. Del resto, quando la celebrità arriva, arriva sul serio: può portarsi dietro un sacco di schifezze che agli uomini piacciono molto. Nell’estate del 2006 Robin era uno di quegli uomini. Ricoverato in una stanza della Fondazione Hazelden a Newberg, nell’Oregon, aveva scollinato la cima del successo per poi precipitare e toccare il fondo dell’eccesso. Era lì per togliersi le schifezze di dosso.
Nove anni prima era riuscito dopo quattro nomination a togliersi la soddisfazione più grande. Sulla sua scrivania transitavano copioni da tutte le parti e da almeno due milioni di dollari a interpretazione. Ma il fatto che lasciasse cadere tutte quelle ricche offerte non era solo perché da uomo ricco poteva permetterselo. Ora che il suo stato di attore si era affermato nei set di Hollywood e nel jet set internazionale, era la carriera che doveva a quel punto essere fermata per dirigerla verso un obiettivo preciso: la statuetta. Continuare a correre alla velocità dei film commerciali e dei fiumi di dollari che scorrevano tra le sue mani, non lo avrebbe portato al traguardo che lui voleva tagliare: impugnarla sul palco degli Academy Awards. Per questo tagliava tutte le proposte che gli arrivavano sul tavolo per scegliere solo quella che gli avrebbe cucito addosso una parte capace di portarlo oltre la nomination.
Il suo posto era in terza fila, nella corsia laterale dello Shrine Auditorium di Los Angeles. Sul palco c’era Billy Crystal a condurre la serata di premiazioni. Robin stava solo aspettando che qualcuno lo chiamasse per salirci sopra a ritirare quello che da 10 anni sembrava tirarsi troppo per le lunghe. Come lunga era la lista di messaggi che ricevette il giorno dopo. Christopher Reeve, Steven Spielberg, Richard Dreyfuss, Chris Columbus, Steve Jobs, George Lucas, Francis Ford Coppola, Anthony Hopkins, Oliver Sacks, Ted Kennedy, Jeff Bridges, l’ufficio postale del suo quartiere, il suo meccanico di fiducia. Se tutta quella gente stava cercando di mettersi in contatto con lui significava che qualcosa era andato al di là dei suoi sogni. Fu il genio ribelle di due ragazzi a cucirgli addosso la parte del represso dottor Maguire. Gli sceneggiatori Matt Demon e Ben Affleck avevano scritto due monologhi per il film Will Hunting. Recitati da Robin Williams non sarebbero passati inosservati ai giudici dell’Academy di Hollywood.
«Sai, ne avevo bisogno». Salire sul palcoscenico del Throckmorton Theatre nello sconosciuto paese di Mill Valley era un modo di rinchiudersi nell’anonimato per proteggersi dalla fama da Oscar. Dopo le riunioni con gli Alcolisti Anonimi si esibiva in numeri di cabaret improvvisati e iniziò a lavorare a un monologo teatrale. Weapons of Self Destruction riportò Robin non solo di fronte a sé stesso, ma anche davanti a un pubblico: aveva bisogno di sentire che lo amavano ancora. Fino a quando un giorno fu costretto ad ammettere di non poterlo fare più: «Non so più come si fa a farvi ridere». Confessarlo mentre piangeva dimostrava fino a che punto avesse sofferto. Un conto era riconoscere che la sua carriera aveva da tempo preso la via del declino, un altro era prendere atto che con il corpo non avrebbe più potuto capovolgerla. Una malattia degenerativa dalla lenta regressione quotidiana lo avrebbe lasciato senza quella sfacciata vitalità fulminante che fece colpo già ai suoi primi esordi.
«Ci vuole un alieno». A metà del quinto anno gli autori erano rimasti senza idee: non sapevano più che rivale inventarsi per Fonzie. Il creatore del telefilm più amato negli Stati Uniti chiese consiglio a suo figlio di nove anni: Scott gli parlò del film Guerre Stellari che era uscito l’estate precedente. Quando il giorno dopo Gary Marshall si presentò sul set chiese se qualcuno conoscesse un marziano divertente. Fu Al Molinaro, il proprietario del fast food di Happy Days, a fare il nome di Robin Williams. Quell’alieno diventò Mork in un episodio che andò in onda il 28 febbraio del 1978. Quel giorno fece il pieno di ascolti: 23,8 milioni di spettatori. Bastò una telefonata del capo della casa di produzione cinematografica Paramount a farlo diventare Mork & Mindy. Michael Eisner chiamò Marshall per conoscere le novità da inserire nel palinsesto in corso di preparazione. «Be’, c’è un ragazzo con un gran talento che meriterebbe un telefilm tutto suo: ha la camicia hawaiana, i pantaloni larghi e le bretelle arcobaleno».
Andrea Ingrosso
Copywriter – Autore di scrittura per le aziende.
© 2022 Mamy
